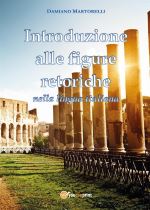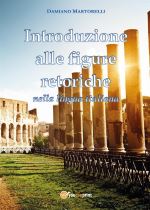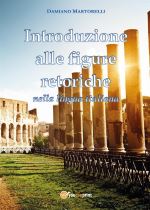Estratto dal volume di D. Martorelli "Introduzione alle figure retoriche nella lingua italiana", ed. Youcanprint, 2017
1.1 Figure retoriche in senso stretto
Come accennato nella lezione precedente, la definizione di retorica è oggi quanto mai complessa. Forniamo ora qui alcuni esempi delle principali figure (intese in senso stretto) che si incontrano nella letteratura italiana (sia essa prosa o poesia).
- Allitterazione: la ripetizione di una lettera o di un gruppo di lettere in una o più parole successive; In poesia, nelle canzoni e negli annunci pubblicitari, viene usata per far risaltare determinati effetti musicali e per mettere in evidenza certe parole. Esempi: e caddi come corpo morto cade (Dante); a morsi venir di rabbia ardenti, / con aspri ringhi e ribuffati dossi (Ariosto); E come il vento / odo dormir tra queste piante, io quello / infinito silenzio a questa voce / vo comparando (Leopardi, L'infinito);
- Anacoluto: propriamente una figura grammaticale, cioè una frase in cui la seconda parte non connessa alla prima in modo sintatticamente corretto. Esempio: Ma che l'amore della vita negli uomini non sia naturale, vedi che moltissimi..., Come si dice di Ermotimo che l'anima gli usciva... (Leopardi, Operette morali);
- Anadiplosi o raddoppiamento: dal greco anadíplosis, «duplicazione», anticamente detta anche epanastrofe o reduplicatio, è una figura che consiste nella ripetizione di uno o più elementi terminali di un segmento di discorso, all'inizio del segmento successivo. Esempio: ma la gloria non vedo / non vedo il lauro e 'l ferro ond'eran carchi (Giacomo Leopardi, All'Italia)
- Anafora: la ripetizione di una o più parole all'inizio di periodi, frasi e magari versi successivi: Per me si va nella città dolente, / per me si va nell'etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente (Dante); ecco apparir Gierusalem si vede, / ecco additar Gierusalem si scorge, / ecco da mille voci unitamente / Gierusalemme salutar si sente (Tasso); ora c'insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri... (Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese);
- Anastrofe o inversione: propriamente l'inversione di due o più parole rispetto all'ordine normale con cui si dispongono nella frase ( una forma di iperbato [cfr. dopo] frequentissima in poesia e nella prosa latineggiante): Convenevole cosa , carissime donne... (Boccaccio); Carlo, che vede scompigliata e sciolta / venir sua gente in fuga manifesta (Ariosto); Tremar sentì la man, mentre la fronte / non conosciuta ancor sciolse e scoprio (Tasso); e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo (Leopardi, L'infinito);
- Antanaclasi: dal greco antanàklasis ("riflessione"), è una figura retorica che consiste nell'usare nel medesimo periodo la stessa parola ma con significato diverso, per es.: "non sempre la rosa è rosa"; "il piacere di piacere agli altri". Crea un particolare effetto quando la stessa parola viene pronunciata, in un dialogo, da due interlocutori diversi: il secondo interlocutore riprende una parola già usata dal primo, ma gliela ritorce contro argutamente o polemicamente, attribuendole un senso non previsto (ad es.: Amleto, tu hai molto offeso tuo padre. / Madre, tu hai molto offeso mio padre; da Shakespeare).
- Antitesi: la contrapposizione di concetti opposti o comunque fortemente divergenti: Non fronda verde, ma di color fosco; / non rami schietti, ma nodosi e rivolti; / non pomi v'eran, ma stecchi con tosco (Dante), Pace non trovo, et non o da far guerra; / e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio; et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra... (Petrarca); I modi di Bireno empii e profani / pietosi e santi riputati foro (Ariosto); a dar si volse / vita con l'acqua a chi co 'l ferro uccise (Tasso); e gli altri augelli contenti, a gara insieme / per lo libero ciel fan mille giri / ... / tu pensoso in disparte il tutto miri (Leopardi, II passero solitario);
- Apostrofe: il rivolgersi direttamente a persona o cosa assenti e diverse comunque dal pubblico cui il messaggio nella sua globalità indirizzato: Ahi fiera e maladetta disavventura! non ti bastano le ingiurie che per lo addietro fatto m'avevi... (Bembo); O sonno, o de la queta, umida, ombrosa notte, placido figlio (Della Casa); Ahi pazza Italia! Il tuo furor medesmo / oltre l'alpi, oltre 'l mar destò le risa (Parini); O natura, o natura, / perchè non rendi poi / quel che prometti allor? / perchè di tanto / inganni i figli tuoi? (Leopardi, A Silvia);
- Asindeto: consiste nella soppressione delle normali congiunzioni in una frase, ed il polisindeto, viceversa, consiste nella successione di diverse ripetute congiunzioni: Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto (Ariosto); o selva o campo o stagno o rio / o valle o monte o piano o terra o mare (Ariosto);
- Assonanza e consonanza: sono figure di rilievo soprattutto in testi poetici (in relazione alla rima e ad altri fatti metrici), che nei casi più semplici consistono rispettivamente nell'identità di vocali in due termini vicini (ma separate da consonanti diverse, altrimenti si avrebbe rima) come in dolore/forte, lasso/guardo; e nell'identità di consonanti in due termini vicini (ma in presenza di vocali diverse), es.morte/conforto;
- Bisticcio o paronomasia o annominazione: l'accostamento di due parole foneticamente simili ma semanticamente diverse: ch'i' fui per ritornar più volte volto (Dante); perchè fur negletti / li nostri voti, e voti (= vuoti) in alcun canto (Dante); non ti turbare; e se turbar ti dei, / turbati che di fe' mancato sei (Ariosto);
- Chiasmo: la disposizione di parole corrispondenti in ordine invertito (secondo lo schema ABBA o ABCCBA ecc.) in due frasi successive: Pace non trovo, et non o da far guerra (Petrarca); L'onta irrita lo sdegno a la vendetta, e la vendetta poi l'onta rinova (Tasso); vivi felice, se felice in terra / visse nato mortal (Leopardi, Ultimo canto di Saffo};
- Climax o gradazione: un'enumerazione di termini che hanno significato gradatamente più intenso (climax ascendente) o meno intenso (climax discendente): e con virtude e con fortuna molta / l'urta, l'apre, ruina e mette in volta (Ariosto); che voglia alcun così infamare il nome / de la sua donna e crede e brama e spera (Ariosto), climax rispettivamente ascendente e discendente;
(continua...)